In questo articolo vorremmo trattare con voi di una tematica che riguarda una fase molto delicata di ciascun individuo: la preadolescenza, ossia il passaggio dall’essere bambini a divenire giovani adulti. Questa fase, che per ognuno può avere un momento di inizio cronologicamente diverso, risulta di particolare importanza nello sviluppo delle singole individualità e non sempre è facile da affrontare, sia per chi lo vive in prima persona che per i famigliari. Ne parliamo con la dott.ssa Donatella Cociani, che ogni giorno è al fianco di bambini e ragazzi che affrontano un ricovero ospedaliero nel reparto di Chirurgia dell’IRCCS Burlo Garofolo.
La preadolescenza è una fase di transizione e cambiamento che si verifica tra due fasi specifiche, un ponte tra due momenti fondamentali dello sviluppo: infanzia e adolescenza. Generalmente si palesa tra gli 8 e i 14 anni e coincide spesso con l’ingresso alla scuola media.
Durante questo periodo, si verificano significativi mutamenti fisici legati alla pubertà, nonché cambiamenti nella sfera emotiva e cognitiva. Emerge una crescente ricerca di autonomia e di identità, in cui le amicizie diventano centrali. Si sviluppa una maggiore consapevolezza di sé e del mondo circostante, rendendo questa età un periodo delicato ma cruciale per la crescita.

I genitori si trovano, dunque, a dover imparare a leggere i segnali del cambiamento e accompagnare i propri figli in questa fase delicata di:
- Sviluppo fisico:
Iniziano i segni della pubertà, con cambiamenti rapidi e talvolta repentini nel corpo. - Cambiamenti cognitivi:
Il pensiero diventa più ipotetico e astratto e si sviluppano nuove capacità di ragionamento. - Sviluppo emotivo:
Si manifestano fluttuazioni dell’umore e una maggiore consapevolezza delle emozioni, ma anche incertezze e sfide legate all’autostima. - Cambiamenti sociali:
Le amicizie assumono un’importanza fondamentale, diventando un punto di riferimento e di confronto primario. Si desidera una maggiore autonomia dai genitori. - Ricerca di identità:
Inizia un processo di costruzione della propria identità, con l’esplorazione dei propri valori e delle proprie aspirazioni.
Aspetti molto importanti da considerare sono le possibili reazioni dei genitori a tali cambiamenti, che, ovviamente, nella quotidianità non risultano così chiari e comprensibili come nello schema precedente, anzi! Spesso si fa molta fatica a capire cosa stia succedendo al proprio “bambino” e, per quanto consapevoli che la preadolescenza sia dietro l’angolo, non sempre si è pronti ad affrontarla.
Insomma, l’ingresso in questa fase della vita può essere una grande sfida sia per il genitore quanto per il figlio stesso, che può trovarsi in mezzo a un grande caos di pensieri, emozioni e sentimenti, difficili da ammettere e accettare. Se da un lato i bambini in crescita sentono la necessità di staccarsi dall’immagine di sé “bambino” allo stesso tempo può essere difficile abbandonare il ruolo del “piccolo” per iniziare ad affrontare le responsabilità che comportano il divenire adulto.

In questa grande ambiguità ci sono alcune parole chiave, o vere e proprie sfide, da tenere in considerazione rispetto al passaggio alla preadolescenza:
AUTOSTIMA
Si tratta di un periodo di incertezze, specialmente riguardo al proprio corpo e alle proprie capacità, per cui è importante offrire supporto costante facendo attenzione al giudizio.
AUTONOMIA
I preadolescenti cercano indipendenza, ma allo stesso tempo necessitano di sentirsi ancora tutelati dall’ambiente circostante. Di conseguenza, è importante che possano sperimentarsi sapendo di poter contare sul supporto del genitore, se servisse.
REGOLE E COERENZA
Fondamentale è stabilire delle regole chiare e condivise in modo naturale che, per quanto probabilmente osteggiate dal figlio, fungono da base sicura per la sperimentazione della loro autonomia. Importante è che anche il genitore rispetti regole prefissate, in modo da risultare esso stesso coerente con le richieste poste al figlio.
COMUNICAZIONE
Nonostante talvolta risulti difficile, è necessario mantenere sempre un dialogo aperto e accogliente, in modo che il preadolescente possa sentirsi libero di esprimere tutti i propri dubbi. Fondamentale è cercare di non far trasparire critiche o pregiudizi che potrebbero creare indisposizione da parte del figlio alla condivisione.
L’arrivo della preadolescenza segna, dunque, un momento molto particolare all’interno delle dinamiche familiari, portando spesso naturale scompiglio. Genitori e figli sono entrambi coinvolti da questa fase e dovrebbero riuscire a ritrovare e ricostruire un nuovo equilibrio.
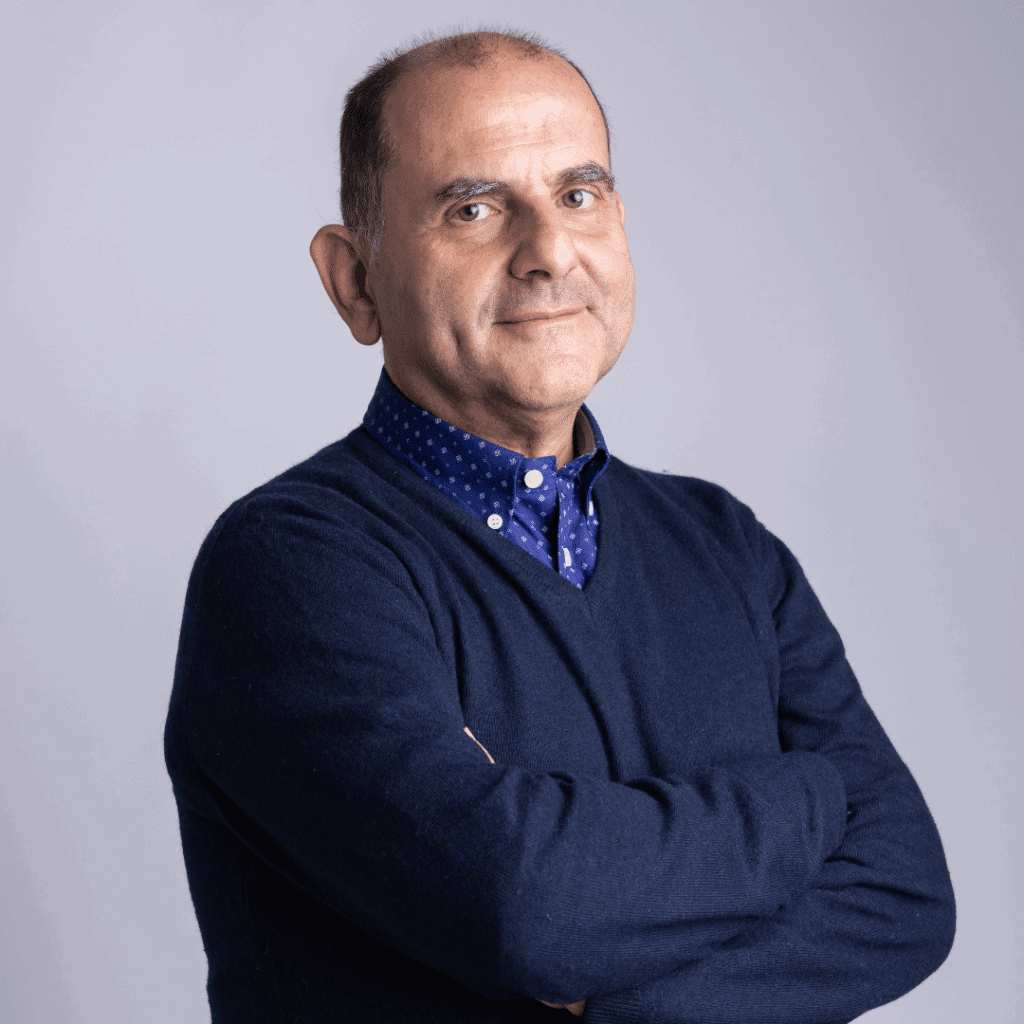
Lui è Alberto Pellai, un noto psicologo e studioso dell’età evolutiva, nonché papà di quattro figli. Partendo dalla propria esperienza come genitore di un preadolescente, si è concentrato sullo studio di questa fase della vita, giungendo a dieci punti di supporto a genitori di bambini in crescita. Ecco quali sono:
Dieci punti salienti per genitori di figli preadolescenti:
1) Nella preadolescenza è normale che i figli cambino. Il cambiamento fa parte della crescita ed è giocoforza che, con l’arrivo della preadolescenza, il figlio non sia più il bambino obbediente e sintonizzato sulle aspettative del genitore, come era fino a pochi mesi prima.
2) Non percepire il loro atteggiamento come una mancanza di affetto. Alcune volte, i genitori restano delusi dal comportamento dei figli e percepiscono il loro allontanamento come una sorta di abbandono amoroso, come se il figlio di punto in bianco non volesse più bene al genitore.
“L’amore non c’entra e non è messo in discussione, quel che il figlio sta cercando con questo suo comportamento è mettere una sorta di barriera di separazione dal genitore, quasi a voler sancire un processo fisiologico di differenziazione da lui” sostiene Pellai.
Non per niente, il figlio a volte manifesta concretamente questa sua esigenza chiudendosi nella sua camera e mettendo alla porta tanto di cartello “bussare prima di entrare” o “non disturbare”, per farci capire senza mezzi termini che è altro da noi.
3) Interrompere la comunicazione se supera il limite. Nel processo di separazione, rabbia e insubordinazione sono lecite, ma è importante che il genitore continui a fare l’adulto, conservando un atteggiamento pacato e non lasciandosi tentare dall’impulso di entrare nella contesa o mettersi in simmetria con il figlio.
Se il figlio superasse il limite alzando la voce, diventando aggressivo, sarebbe meglio interrompere le comunicazioni, aggiungendo espressamente che non abbiamo più niente da dire né da ascoltare, se espresso in tal modo. Il messaggio che si cerca di veicolare è che si è disposti a parlare, ma senza esasperare il conflitto.
4) Dopo la tempesta, si può chiarire. Sbollita la rabbia e terminata la fase di maggiore attivazione emotiva, solitamente il ragazzo torna ad una situazione di tranquillità, su cui non ha senso ritornare con prediche o rimproveri. Piuttosto, si può cercare di trasmettergli come alcuni atteggiamenti risultino difficili da gestire, e stimolare una riflessione sulle emozioni provate dal genitore e sulla difficoltà nel gestire la situazione. Ciò può aiutare a rafforzare un pensiero critico e consapevole sulle proprie reazioni.
5) Non avere paura di dire di no (nel timore di una loro reazione aggressiva). Anche in questa fase di vita, un genitore dovrebbe mantenere saldo il suo ruolo, avendo coraggio di dire di no, mantenendolo anche in caso di ostilità e negazione. In questo modo, passa il messaggio secondo cui quel no non è un capriccio di un genitore cattivo, ma è parte di un pensiero strutturato rispetto a dinieghi e concessioni.
6) Tollerare la frustrazione del ragazzo per i nostri no. È fondamentale mantenere la coerenza rispetto ai “no” e alle regole imposte, soprattutto facendo attenzione che sia il genitore in primis a mantenere il punto nonostante le possibili proteste dei figli. Il sentirsi insultare o rimproverare come peggiori genitori del mondo deve essere ovviamente interpretato come uno sfogo del momento, senza cedere dalla posizione iniziale.
7) Cosa fare se dicono: “tu non mi capisci”. Durante una discussione, potrebbe essere una recriminazione piuttosto frequente da parte dei figli verso i genitori, i quali, nonostante il clima effervescente della comunicazione, possono provare a mantenere aperto il dialogo domandando al figlio di aiutarlo a capire meglio.
È importante che il figlio percepisca uno spazio sicuro dove poter esplicitare i propri bisogni o sentimenti e che senta di poter chiedere quello che lo aiuterebbe. Ovviamente le possibili richieste vanno ponderate insieme, e, sia che vengano accettate che respinte, sarebbe opportuna una debita spiegazione della motivazione.
In questa fase di crescita, potrebbe essere normale che vi siano delle richieste spropositate e fuori luogo e, nonostante le possibili proteste davanti a un no, è rassicurante per il figlio sapere di avere un genitore saldo, fermo sulle sue posizioni.
8) Se emerge un paragone con il fratello o la sorella. In caso di recriminazioni rispetto a trattamenti diversi tra fratelli, può essere opportuno ricordare che sebbene i genitori siano sempre gli stessi, i fratelli sono diversi e che dietro a determinati atteggiamenti diversi c’è, appunto, la necessità di dar spazio alle singole individualità. È importante che il figlio senta una risposta di apertura e di accettazione della critica al genitore, senza che venga svalutata o non considerata. Infatti, è bene tenere presente che spesso possono esserci fantasie rispetto al rapporto tra fratello/sorella e i genitori, sin dall’età infantile.
9) Evitare strategie punitive. Generalmente, le punizioni dovrebbero portare a un aumento di senso di responsabilità rispetto alla situazione negativa che le ha generate, con una spiegazione del senso che viene loro attribuito. Tuttavia, se non chiare o coerenti con il misfatto, possono portare a reazioni di rabbia e conseguente non rispetto della punizione, con una possibile escalation di arrabbiature reciproche.
Se la strategia della spiegazione/comprensione non dovesse risultare sufficiente, è possibile passare ad alcune punizioni più rigorose, sempre accompagnate da una spiegazione che le motivi.
10) Tenere a mente che verso i 14 anni passa! L’atteggiamento di insubordinazione dura per tutto il tempo della preadolescenza, all’incirca fino ai 13-14 anni, perché rientra in una fase ben precisa di sviluppo del sistema neuronale del cervello. Dunque, l’importante è resistere e non cadere nelle provocazioni!

Affrontare un ricovero durante la preadolescenza
Se, tra i cambiamenti fisici ed emotivi legati a questa fase di vita così delicata, capitasse di affrontare un percorso di ricovero o un intervento chirurgico, potrebbe essere necessario prestare ulteriore attenzione alle possibili reazioni di un figlio preadolescente.
Il pensiero di un corpo in cambiamento può essere già molto difficile da gestire. Se, in più, vi è l’idea di una manipolazione chirurgica, è necessario che il ragazzo sia coinvolto in quello che dovrà succedere e abbia modo e tempo di comprenderlo e metabolizzarlo.
Potrebbero manifestarsi reazioni rabbiose verso la situazione, oppure una sensazione di sollievo e di autoefficacia, per essere in grado di affrontare una condizione vissuta come negativa.
Il genitore può accogliere le eventuali reazioni e integrarle nel percorso chirurgico, tenendosi pronto a dare spazio anche a eventuali domande e perplessità.
In questa fase è possibile che i figli abbiano accesso a informazioni trovate sul web, che da un lato possono aiutarli per prepararsi a cosa andranno incontro, ma dall’altro esporli a spiegazioni poco professionali, con il rischio di incrementare dubbi e fantasie.
Infatti, sebbene abbiano superato la fase del “pensiero magico” tipico dell’infanzia, continua a esistere la possibilità di crearsi fantasie rispetto alle situazioni di cui non si hanno informazioni certe (in realtà ci accompagnano anche nell’età adulta).
A tal proposito, nella fase di vita preadolescenziale, si potrebbero fronteggiare momenti cosiddetti “regressivi” a comportamenti infantili. Del resto, si tratta di un momento della vita alquanto altalenante, specialmente in situazioni di alto stress emotivo come un ricovero ospedaliero. In questo caso, il genitore può comprendere la criticità del momento e mantenere, in quanto adulto, un equilibrio che accolga le paure del figlio senza farsi travolgere dal momento di possibile “infantilismo”.
IL CORPO: CICATRICI E DISABILITÀ
Rispetto alla gestione della corporeità, che in questa fase di vita è centrale, vorremmo proporre una riflessione sulle cicatrici, esiti dei possibili interventi chirurgici.
I segni lasciati sul fisico possono essere interpretati in modi diversi da ogni bambino: dalla vergogna per qualcosa che è percepito come diverso dalla normalità, all’orgoglio per aver affrontato una situazione difficile. Qualcuno potrebbe provare imbarazzo, specialmente nel genere femminile, con tentativi di nascondere i segni sul corpo.
Qualora venga manifestato orgoglio per le proprie cicatrici, la gestione da parte del genitore può risultare più semplice. Tuttavia, nel caso di imbarazzo e vergogna, è importante non sminuire le sensazioni esternate dal proprio figlio, ma cercare di accompagnarlo verso l’accettazione della sua nuova fisicità.

Un’ulteriore fondamentale tematica è quella della gestione di una disabilità fisica e l’attenzione alla corporeità e al bisogno di autostima e autonomia.
Durante la preadolescenza, disabilità fisiche, intellettive e sensoriali possono fungere sia da sfide che da opportunità per lo sviluppo dell’individuo, specialmente per il raggiungimento dell’autonomia e dell’integrazione sociale. In questo senso, è fondamentale che genitori promuovano l’autostima e consentano la sperimentazione, senza sostituirsi al bambino nei suoi tentativi di crescita. È importante offrirgli supporto e strumenti per superare eventuali barriere sociali, come quelle che possono influenzare la partecipazione ad attività come lo sport o eventi favorevoli alla creazione di relazioni sociali.
Si tratta di un momento della vita in cui le relazioni con i pari sono fondamentali, ma lo è altrettanto sapere di poter contare sui familiari, un porto sicuro in cui i momenti di difficoltà siano ascoltati e compresi.
Tale bisogno è ancor più presente in un preadolescente che presenta disabilità: è importante che egli abbia sempre la possibilità di mettersi alla prova nel mondo sapendo di avere un genitore attento ad accogliere sue eventuali frustrazioni e a sostenere la necessità di continuare a provare.
Siamo consapevoli di aver probabilmente aperto un vaso di Pandora rispetto alla questione della preadolescenza, ma ci auguriamo che queste righe possano avervi offerto degli spunti di riflessione su ciò che il dottor Pellai definisce un momento di “tsunami” nella vita familiare.
Se voleste approfondire l’argomento, ecco i riferimenti del testo citato:
- “L’età dello tsunami. Come sopravvivere a un figlio preadolescente” di A. Pellai, B.Tamburini, De Agostini Editore.
Vi auguriamo tanta pazienza e… aspettate che lo tsunami passi!
A cura di: Dott.ssa Donatella Cociani, psicologa psicoterapeuta responsabile del Progetto Accoglienza di ABC.
